Quando lo sport vince il razzismo
Su Avvenire del 18 aprile ho letto la storia molto bella, che non conoscevo, di un giocatore di baseball.
Vi riporto l'articolo di Mauro Berruto, che ce la racconta.
«Non sono interessato alla vostra simpatia o antipatia, tutto quello che chiedo è che mi rispettiate come essere umano».
Queste parole sono di Jackie Robinson, uno dei tanti giocatori di baseball passati per la Major League, ma uno dei pochissimi a lasciare un segno indelebile del suo passaggio.
Robinson è il detentore di un record imbattibile: fu il primo giocatore afroamericano ad arrivare nella Lega professionistica Usa. Jackie era stato introdotto allo sport dal suo fratello maggiore, Mack. Uno che, per capirci, aveva vinto la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Berlino nei 200 metri, dietro a un certo Jesse Owens. Jackie aveva un talento sportivo davvero eclettico e, dopo aver vagabondato fra le discipline principali della cultura nordamericana (basket, football americano, atletica leggera addirittura tennis), scelse il baseball. Non era neppure lo sport che gli veniva meglio, il suo sogno era giocare a football americano, ma i tempi erano duri e per Jackie l’unica strada che si aprì fu quella di un club di Kansas City che partecipava a quella che si chiamava, senza possibilità di interpretazione, la Negro League, lega riservata ai giocatori afroamericani. Tuttavia il talento, quando è cristallino, attrae interesse, l’interesse (quando si parla di sport professionistico) diventa presto interesse economico e così, pur in mezzo a mille tensioni e minacce, a Jackie venne proposto un contratto per la Major League. Il suo nuovo club, tuttavia, stava superando una specie di confine che fino a quel giorno era stato invalicabile e volle, in qualche modo, tutelarsi. Nel contratto di Jackie c’erano infatti alcune clausole che avevano un comune denominatore: non avrebbe dovuto lamentarsi o reagire mai di fronte a nessuna provocazione dei suoi avversari, dei suoi compagni o dei tifosi specificando con una certa dose di cinica chiarezza che quella richiesta sarebbe stata valida anche se qualcuno gli avesse «sputato in faccia».
Jackie mise la sua firma sotto quelle parole, in cambio di 600 dollari al mese, ma probabilmente consapevole che quanto stava facendo avrebbe, per sempre, cambiato il suo sport. Fu in quel clima che il 15 aprile 1947, davanti a 23.000 spettatori, esordì all’Ebbets Field di Brooklyn, indossando la maglia n. 42 dei Dodgers.
Insulti, minacce, sputi non mancarono quel giorno, né mai, in ogni stadio e in centinaia di occasioni. Alcuni suoi compagni firmavano petizioni per allontanarlo dalla squadra, svariati avversari si rifiutavano di scendere in campo quando c’era lui. Tuttavia a Jackie bastarono un paio di anni per diventare il trascinatore dei Dodgers verso il titolo e, per forza o per amore, ottenere rispetto a suon di fuoricampo. Nel 1950 diventò addirittura attore, per raccontare in un film la storia della sua vita. La sua parabola non si fermò: continuò a rompere barriere da atleta, da manager (fu il primo uomo di colore a raggiungere la vicepresidenza di una grande azienda americana nel settore della ristorazione), da imprenditore (fondò una compagnia di costruzione per la realizzazione di case per famiglie a basso reddito). Repubblicano convinto si spese nel mondo della politica e, nel 1962, fu il primo atleta di colore a entrare nella Hall of Fame del baseball americano. Consumato dal diabete morì giovane, appena cinquantatreenne, nel 1972. Il 15 aprile 1997, in occasione del 50esimo da quell’esordio che aveva cambiato per sempre la storia del baseball e degli Stati Uniti, la Major League chiese a tutti i suoi club di ritirare la maglia numero 42.
 Proprio per questo motivo, ogni 15 aprile, il baseball americano festeggia il
Jackie Robinson Day in un modo delicato, semplice, simbolico: i giocatori di tutte le squadre della Major League, così come allenatori e arbitri, scendono in campo con il numero 42.
Proprio per questo motivo, ogni 15 aprile, il baseball americano festeggia il
Jackie Robinson Day in un modo delicato, semplice, simbolico: i giocatori di tutte le squadre della Major League, così come allenatori e arbitri, scendono in campo con il numero 42.
È l’unico giorno in cui è possibile farlo, per commemorare un atleta e un uomo che riceveva minacce di morte ogni volta che varcava l’ingresso di uno stadio e che oggi, proprio all'ingresso dello stadio dove esordì quel famoso 15 aprile, ha, tutto per sé, un monumento alla cui base c’è scritto:
«Non sono interessato alla vostra simpatia o antipatia, tutto quello che chiedo è che mi rispettiate come essere umano».
Queste parole sono di Jackie Robinson, uno dei tanti giocatori di baseball passati per la Major League, ma uno dei pochissimi a lasciare un segno indelebile del suo passaggio.
Robinson è il detentore di un record imbattibile: fu il primo giocatore afroamericano ad arrivare nella Lega professionistica Usa. Jackie era stato introdotto allo sport dal suo fratello maggiore, Mack. Uno che, per capirci, aveva vinto la medaglia d’argento ai Giochi Olimpici di Berlino nei 200 metri, dietro a un certo Jesse Owens. Jackie aveva un talento sportivo davvero eclettico e, dopo aver vagabondato fra le discipline principali della cultura nordamericana (basket, football americano, atletica leggera addirittura tennis), scelse il baseball. Non era neppure lo sport che gli veniva meglio, il suo sogno era giocare a football americano, ma i tempi erano duri e per Jackie l’unica strada che si aprì fu quella di un club di Kansas City che partecipava a quella che si chiamava, senza possibilità di interpretazione, la Negro League, lega riservata ai giocatori afroamericani. Tuttavia il talento, quando è cristallino, attrae interesse, l’interesse (quando si parla di sport professionistico) diventa presto interesse economico e così, pur in mezzo a mille tensioni e minacce, a Jackie venne proposto un contratto per la Major League. Il suo nuovo club, tuttavia, stava superando una specie di confine che fino a quel giorno era stato invalicabile e volle, in qualche modo, tutelarsi. Nel contratto di Jackie c’erano infatti alcune clausole che avevano un comune denominatore: non avrebbe dovuto lamentarsi o reagire mai di fronte a nessuna provocazione dei suoi avversari, dei suoi compagni o dei tifosi specificando con una certa dose di cinica chiarezza che quella richiesta sarebbe stata valida anche se qualcuno gli avesse «sputato in faccia».
Jackie mise la sua firma sotto quelle parole, in cambio di 600 dollari al mese, ma probabilmente consapevole che quanto stava facendo avrebbe, per sempre, cambiato il suo sport. Fu in quel clima che il 15 aprile 1947, davanti a 23.000 spettatori, esordì all’Ebbets Field di Brooklyn, indossando la maglia n. 42 dei Dodgers.
Insulti, minacce, sputi non mancarono quel giorno, né mai, in ogni stadio e in centinaia di occasioni. Alcuni suoi compagni firmavano petizioni per allontanarlo dalla squadra, svariati avversari si rifiutavano di scendere in campo quando c’era lui. Tuttavia a Jackie bastarono un paio di anni per diventare il trascinatore dei Dodgers verso il titolo e, per forza o per amore, ottenere rispetto a suon di fuoricampo. Nel 1950 diventò addirittura attore, per raccontare in un film la storia della sua vita. La sua parabola non si fermò: continuò a rompere barriere da atleta, da manager (fu il primo uomo di colore a raggiungere la vicepresidenza di una grande azienda americana nel settore della ristorazione), da imprenditore (fondò una compagnia di costruzione per la realizzazione di case per famiglie a basso reddito). Repubblicano convinto si spese nel mondo della politica e, nel 1962, fu il primo atleta di colore a entrare nella Hall of Fame del baseball americano. Consumato dal diabete morì giovane, appena cinquantatreenne, nel 1972. Il 15 aprile 1997, in occasione del 50esimo da quell’esordio che aveva cambiato per sempre la storia del baseball e degli Stati Uniti, la Major League chiese a tutti i suoi club di ritirare la maglia numero 42.
 Proprio per questo motivo, ogni 15 aprile, il baseball americano festeggia il
Jackie Robinson Day in un modo delicato, semplice, simbolico: i giocatori di tutte le squadre della Major League, così come allenatori e arbitri, scendono in campo con il numero 42.
Proprio per questo motivo, ogni 15 aprile, il baseball americano festeggia il
Jackie Robinson Day in un modo delicato, semplice, simbolico: i giocatori di tutte le squadre della Major League, così come allenatori e arbitri, scendono in campo con il numero 42.È l’unico giorno in cui è possibile farlo, per commemorare un atleta e un uomo che riceveva minacce di morte ogni volta che varcava l’ingresso di uno stadio e che oggi, proprio all'ingresso dello stadio dove esordì quel famoso 15 aprile, ha, tutto per sé, un monumento alla cui base c’è scritto:



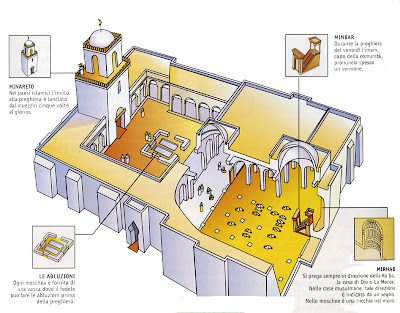

Commenti
Posta un commento